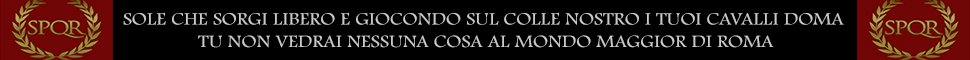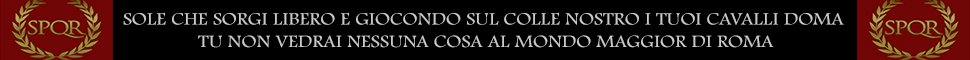|
Categorie Accademia Romanesca
Scritto da Er Pasquino
mercoledì, 28 Gennaio alle ore 08:53
|
Il luogo più immediato e diretto in cui si esprime la lingua romanesca è la poesia e la forma poetica che meglio di ogni altra esprime la concretezza, la concisione e la spietatezza dell’animo romanesco, è senz’altro il sonetto.
Il sonetto è quello che un certo Wolfgang ai primi dell’ottocento definiva: “il degno scrigno del verso d’oro della poesia italiana: l’endecasillabo”. Tradotto in parole nostre: mejo dell’endecasillabo nun ce sò versi.
Er sonetto è fatto de quattordici endecasillabi.
Cerchiamo di capire: il verso poetico è basato sulle sillabe in cui si può dividere quel verso. Es. “Forza Roma” è formato da 4 sillabe. “Core de Roma” è un quinario (cinque sillabe). “Me batte ‘r core quanno canto l’inno” è un endecasillabo. (dividiamo: me-bat-te’r-co-re-quan-no-can-to-l’in-no).
Indubbiamente la musicalità di un verso fatto da undici sillabe, non ha confronti con altri tipi di metrica (la metrica è quella faccenda che regola i versi poetici).
Il sonetto è formato da quattordici endecasillabi: più musicale di così…. ed è composto di due quartine e due terzine.
Le quartine sono quattro versi che rimano a due a due, le terzine sono tre versi che rimano a due o tre rime.
Leggete questo sonetto di un poeta contemporaneo: il Rugante.
Colori
Quanno che penzo ar “Giallo”… sogno er sole,
rivedo er vento mentre culla er grano,
sento odore de stoppia, che, ruffiano,
m’aricorda la fine de le scole;
sbarbaji de limone e girasole,
colori de ‘n autunno paesano,
o l’emozzione de tuffà la mano
tra queli ricci, pe’ infilà du’ viole.
Poi bacio er “Rosso”: er rosso dell’amore,
de la bandiera che nun butto via
e me tengo inzerrata drento ar core;
volo: cor vino, o co ‘na malatia (1)
che inturcina la gioja cor dolore:
‘sti du’ colori, sò la vita mia!
1=il “tifo”
|
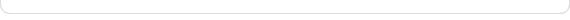
Ripassiamo un po’ di regole
Categorie Accademia Romanesca
Scritto da Er Pasquino
mercoledì, 28 Gennaio alle ore 08:39
|
Anche la lingua di Roma ha una sua grammatica e una sua sintassi. Sono le regole dello scrivere romanesco affinatesi negli scritti degli autori classici: da Belli, a Pascarella, a Trilussa, a Marè, a Dell’Arco, a Roberti.
Un conto è parlare, un conto è scrivere e in queste pagine scopriremo alcune regole fondamentali dello scrivere romanesco.
L’uso dei verbi e l’uso degli articoli.
L’uso dei verbi
A Roma non si usa il verbo “avere” ma il verbo “avé”, con l’accento sulla é, come quello di “perché”. Non si usa l’apostrofo, ma l’accento “acuto” (che è il contrario dell’accento “grave”, quello di “sarà”, “farò” “è”): l’apostrofo si usa quando una parola viene troncata.
Siccome nessun romano (o meglio: romanesco) dirà mai (e ha mai detto o scritto) “avere”, il dialetto ha selezionato il verbo “avé”, e basta: non è un “avere” troncato, è proprio e soltanto “avé”, quindi non una parola la cui troncatura è sostituita dall’apostrofo, ma una parola nata così.
Per essere più precisi, nel parlato (e nello scritto) comune è molto più frequente l’uso del verbo “avecce”, usato come sottolineatura di possesso.
Coniugazione del verbo AVERCI:
Adesso viene il bello: in italiano la coniugazione del verbo “averci” (corrispondente ad “avecce”) si declina: “ci ho”, “ci hai” “ci ha” ecc. In romanesco le cose cambiano. Quindi, come si declina il verbo “avecce”? Così:
io ciò
tu ciai (o ciài)
lui (o lei) cià
noi ciavemo (o ciàvemo)
voi ciavete (o ciàvete)
loro cianno (o ciànno)
Questo è! Solo questa è la forma ortografica corretta! Tutto il resto è “sbajato”. Senza appello.
L’uso degli articoli – Gli articoli determinativi
- in italiano sono:
il – lo – la, al singolare;
i – gli –le, al plurale.
- In romanesco sono:
er – lo – la, al singolare;
li – li – le, al plurale.
Quello su cui si potrebbe fare confusione è l’articolo determinativo plurale maschile.
- in italiano si dice
Al singolare: il, lo.
Plurale: i, gli.
In romanesco si dice (ma soprattutto: si scrive) solo e soltanto “li”.
Mentre per il singolare, nel parlato, viene tollerata (ma rimane forma gergale e quindi scorretta) la forma contratta ‘o (es: “nun sta a fà ‘o stronzo); per il plurale non ci sono deroghe: si dice (ma soprattutto: si scrive) sempre e comunque “li” (es: li laziali, li scemi, l’irricucibili).
|
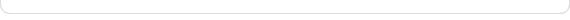
Categorie Accademia Romanesca
Scritto da Er Pasquino
mercoledì, 28 Gennaio alle ore 08:28
|
L’Accademia Romanesca nasce dall’iniziativa di alcuni appassionati con l’intento di divulgare gli studi e le ricerche effettuate sulla cultura e sul linguaggio del popolo di Roma.
Perché “del popolo” ? Perché il fatto di essere popolare identifica la cultura “romanesca” e la differenzia da quella “romana”. Dal dialetto alle tradizioni, esistono grosse diversità, non solo economiche e culturali, tra il popolo e le classi “colte”: nei secoli il linguaggio di quella che era la nobiltà, poi la borghesia, infine il “generone”, si è sempre diversificato da quello “della strada”. Ma è proprio a quello che l’Accademia si rifà, in quanto ritenuto il più vero, immediato e spontaneo: il linguaggio dell’emotività.
Lo scopo principale dell’Accademia è quindi quello di divulgare e rendere accessibile a tutti il dialetto “romanesco”, attraverso la lettura e lo studio dei testi dei migliori autori dialettali del passato e del presente.
La scelta di usare un linguaggio “popolare” di uso comune, porta come conseguenza la adozione di un “codice dialettale” usato, ma soprattutto compreso, da chi tutti i giorni contribuisce a plasmare questa meravigliosa lingua che è il dialetto.
L’Accademia ha deciso di adottare quello che è il dialetto attuale (attenzione: il dialetto e non il “gergo”), sicuramente più vicino a quello di Trilussa che non a quello di Belli.
La divulgazione da parte dell’Accademia di tutto ciò che concerne la cultura di Roma è una componente essenziale per comprendere l’evoluzione della società popolare di questa città unica.
Per saperne di più sull’Accademia Romanesca e partecipare alla sua vita è possibile collegarsi al sito http://www.accademiaromanesca.it oppure compilare il format cliccando qui.
Ma come per magia, caliamoci improvvisamente nel passato. Roma 1830, mese di ottobre … una citazione Storica presa dal libro: La Roma di Bartolomeo Pinelli nelle più belle incisioni del «Pittor de Trastevere», commenta un’incisione del pittore raffigurante un’esibizione poetica tra popolani in un’osteria di Testaccio in piena età papalina !
citazione : La passione del popolo romano per il canto e la poesia era proverbiale. Durante la bella stagione e soprattutto in ottobre, tutte le domeniche sera, nelle osterie all’aperto, a Trastevere, ai Monti, alla Regola o nelle osteria FORI PORTA, si radunavano venti o trenta amici, uomini e donne, e li, su due piedi, si tenevano interminabili gare poetiche fra due o tre improvvisatori popolari, che si sfidavano fra loro, a botta e risposta, producendosi in esibizioni poetiche e canore su tutti gli argomenti: sulla storia romana, sulla storia greca, sulla Guerra di Troia, sulla mitologia, sulla storia sacra, sui paladini di Francia.
Un CALASCIONE o un mandolino accompagnavano i versi in ottava rima, che erano cantati, con voce generalmente intonata e armoniosa, dai due o tre poeti improvvisatori. Il Pubblico ascoltava in religioso silenzio e con commossa partecipazione quelle STORIE cantate in ottava, al modo degli antichi aedi popolari, e parteggiava per l’uno o per l’altro degli sfidanti. A volte queste omeriche sfide poetiche duravano anche due o tre giorni di seguito, senza che gli sfidanti ripossassero neanche la notte. I poeti, nella foga del canto, si accaloravano sempre più, passando abilmente da un argomento all’altro, a seconda dell’ultima battuta dell’avversario. E quelli che li stavano a sentire, per ore ed ore, senza mai stancarsi, li acclamavano volta per volta, alla fine di ogni battuta.


Bartolomeo Pinelli – Il Poeta improvvisatore a Testaccio nel mese di ottobre.
Disegni e i inc. 1830
|
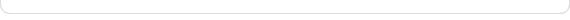
ACCADEMIA ROMANESCA e COREDEROMA
Categorie Accademia Romanesca
Scritto da Er Pasquino
martedì, 27 Gennaio alle ore 02:22
|
LEZIONI : La lingua del popolo di Roma
-
Ripassiamo un po’ di regole – l’uso dei verbi e degli articoli..
-
La poesia romanesca – la costruzione di un sonetto..
Le prossime schede saranno inserite a cadenza xxxxx
Ma come per magia, caliamoci improvvisamente nel passato. Roma 1830, mese di ottobre … una citazione Storica presa dal libro: Bartolomeo Pinelli Compton e Newton editore, commenta un’incisione del pittore raffigurante un’esibizione poetica tra popolani in un’osteria di Testaccio in piena età papalina !
citazione : La passione del popolo romano per il canto e la poesia era proverbiale. Durante la bella stagione e soprattutto in ottobre, tutte le domeniche sera, nelle osterie all’aperto, a Trastevere, ai Monti, alla Regola o nelle osteria FORI PORTA, si radunavano venti o trenta amici, uomini e donne, e li, su due piedi, si tenevano interminabili gare poetiche fra due o tre improvvisatori popolari, che si sfidavano fra loro, a botta e risposta, producendosi in esibizioni poetiche e canore su tutti gli argomenti: sulla storia romana, sulla storia greca, sulla Guerra di Troia, sulla mitologia, sulla storia sacra, sui paladini di Francia.
Un CALASCIONE o un mandolino accompagnavano i versi in ottava rima, che erano cantati, con voce generalmente intonata e armoniosa, dai due o tre poeti improvvisatori. Il Pubblico ascoltava in religioso silenzio e con commossa partecipazione quelle STORIE cantate in ottava, al modo degli antichi aedi popolari, e parteggiava per l’uno o per l’altro degli sfidanti. A volte queste omeriche sfide poetiche duravano anche due o tre giorni di seguito, senza che gli sfidanti ripossassero neanche la notte. I poeti, nella foga del canto, si accaloravano sempre più, passando abilmente da un argomento all’altro, a seconda dell’ultima battuta dell’avversario. E quelli che li stavano a sentire, per ore ed ore, senza mai stancarsi, li acclamavano volta per volta, alla fine di ogni battuta.


Bartolomeo Pinelli – Il Poeta improvvisatore a Testaccio nel mese di ottobre.
Disegni e i inc. 1830
|
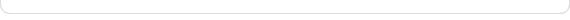
| |
|