Categorie Editoria Ultimi arrivi CDR Scritto da Danilo Leo domenica, 18 Marzo alle ore 07:24
|
Stefano Pellegrini di quelle speranze e di quelle illusioni ne aveva suscitate parecchie. Helenio Herrera lo aveva fatto esordire in serie A il 14 marzo del 1971 quando non aveva ancora compiuto 18 anni, niente meno che in un derby di campionato. Il suo primo gol in serie A era stato una perla da cineteca, una rovesciata acrobatica che aveva mandato il pallone a gonfiare la rete dell’Atalanta e dato la vittoria alla Roma. Fu speciale anche il suo primo gol “europeo”, segnato contro il Dunav Ruse, primo gol della Roma nella neonata competizione di coppa Uefa. Chi scrive potrebbe essere stato l’ultimo ad intervistarlo, visto che con il calcio pellegrini aveva chiuso tanti anni fa e si era dedicato a mandare avanti l’impresa che condivideva con la moglie. Avevamo parlato di un episodio specifico, un suo gol all’Ascoli che nel 1976 aveva salvato la Lazio dalla B e spedito gli ascolani nella cadetteria. Si era così beccato gli insulti dei tifosi romanisti e, peggio ancora, i rimbrotti di sua moglie Mariangela, marchigiana doc. Mi raccontò della sua carriera. Gli inizi nella gloriosa Tevere Roma, poi il passaggio alla Roma Primavera campione d’Italia nel 1972-’73, dell’emozione incredibile dell’esordio nel derby (“Lei domenica gioca, mi disse Herrera. Ed io credevo si rivolgesse ad un altro”). Mi raccontò come il fatto di avere il gol facile fu per lui una sorta di croce e delizia. Lui si sentiva ed era un centrocampista che gli allenatori schieravano in attacco per sfruttarne la vena realizzativa. E questo non gli consentì mai di esprimere il suo talento fino alla fine (“io e Agostino Di Bartolomei in Primavera costituivamo una coppia di mezze ali come non ce ne erano in Italia”). Raccontò la fine del suo rapporto con la Roma, quel gol salva-Lazio non fu del tutto ininfluente. E di come per rimettersi in gioco se ne andò a Barletta in serie C. Per riguadagnarsi la serie A a suon di gol con l’Avellino (“li trovai Rino Marchesi, l’unico allenatore che seppe valorizzarmi davvero come centrocampista”) E dove inciampò nel calcio-scommesse (“sono ancora qui a chiedermi come sia stato possibile falsare una partita, Avellino-Perugia, nella quale non giocai. E come mai mi presi 5 anni di squalifica quando invece Paolo Rossi, che era in campo, ne prese soltanto due. Forse perché io non ero nel frattempo stato acquistato dalla Juventus”). E mi raccontò pure di come, nonostante l’amnistia per la vittoria ai mondiali del 1982 e la chiamata di Fascetti per il Lecce, preferì non rimettersi in gioco (“mi svegliai una mattina con la netta sensazione di non essere più un giocatore di calcio. E la mia carriera finì lì”). |
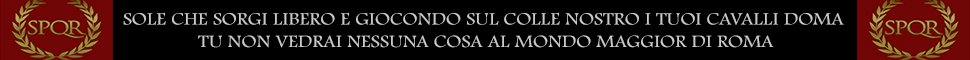



 Stefano Pellegrini se n’è andato a nemmeno 65 anni. Bisogna essere di quelli che hanno tante primavere sulle spalle per ricordarselo. Di quelli che hanno visto la Roma sulle panchine di legno verniciate di verde che c’erano una volta all’Olimpico. Di quelli che, tifando una Rometta senza grandi squilli e ambizioni, speravano ardentemente di trovare finalmente il talento che cercavano nei giovani virgulti che arrivavano dalle giovanili.
Stefano Pellegrini se n’è andato a nemmeno 65 anni. Bisogna essere di quelli che hanno tante primavere sulle spalle per ricordarselo. Di quelli che hanno visto la Roma sulle panchine di legno verniciate di verde che c’erano una volta all’Olimpico. Di quelli che, tifando una Rometta senza grandi squilli e ambizioni, speravano ardentemente di trovare finalmente il talento che cercavano nei giovani virgulti che arrivavano dalle giovanili.