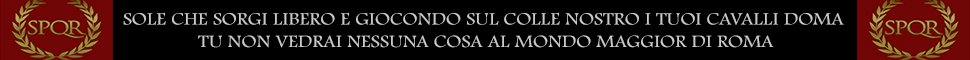Categorie Articoli by Gens Romana Scritto da Marforio lunedì, 6 Ottobre alle ore 08:27
|
Ogni stagione ha la sua icona, un’immagine che ti resta nella mente e che non ti leverai mai più dalla testa. La mia immagine del 2006 è il girotondo della Coppa Italia. Nel 2007 sono i fuochi d’artificio della finale di Coppa Italia a Milano, con San Siro nerazzurro ammutolito. Lo scorso anno è il “daje Roma, daje” urlato da Daniele De Rossi in Roma-Genoa. L’icona di quest’anno è lo sguardo sconsolato e quasi lacrimoso di Luciano Spalletti all’espulsione di Mexes nella partita col Siena. Un’immagine che trasmette impotenza. Un’immagine che divide e non unisce come invece dovrebbe fare, secondo natura e umana comprensione, quella di un uomo sofferente. |