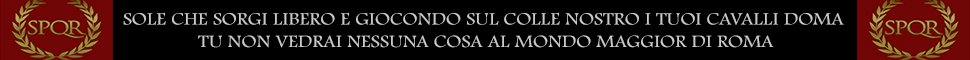Categorie Articoli by Gens Romana Scritto da Marforio domenica, 6 Aprile alle ore 07:55
|
Da quando era tornato dall’Afghanistan, appena prima di Pasqua, Giulio si era deciso a riprendersi Roma. Appena poteva andava in giro per la città e si immergeva nei sapori, nei colori, negli odori, nei suoni e nei ritmi della “sua” Roma. All’inizio aveva fatto fatica a ritrovarsi, a riprendere confidenza con le cose, con la gente. Sei mesi filati sono duri da digerire quando sei lì, e un po’ ti restano dentro anche quando torni, quando la felicità dell’essere tornati si mischia ad un vago senso di smarrimento, persino ad un po’ di paura. La paura di sentirsi estranei a casa propria. Lui che in tanti anni di missioni in giro per il mondo la paura, la propria e quella dei suoi compagni, aveva imparato a rispettarla e a dominarla. E per sentirsi nuovamente a casa propria, finalmente a casa propria, aveva avvertito la necessità viscerale di tornare allo Stadio, a tifare la sua Roma. Perché solo chi non è mai stato lontano da Roma, lontano da casa, si può permettere di scegliere. Di dire oggi vado allo Stadio perché viene il Manchester, o la Juve, o il Milan, domenica non ci andrò, preferisco andare al mare, a fare acquisti o al cinema, trattando la Roma come uno svago o un passatempo come tanti. Per lui era diverso. Per lui la Roma era sorella, madre e amante, di quelle amanti che proprio sul più bello ti respingono e ti lasciano lì ad imprecare, anche se sai benissimo che poi tornerai da lei ad implorarla di renderti felice ancora una volta. Immerso in questi pensieri Giulio si incamminò lungo il tratto di strada che aveva fatto mille volte. Quello che ti porta alla Palla o sotto la Sud. Ma non era la Curva la sua meta anche se gli amici gli avevano offerto l’occasione di tornarci cedendogli il loro posto. Giulio non si sentiva ancora pronto per tornare in Curva e poi non era solo. Al suo fianco c’era Emanuela, sua figlia, nel fiore dei suoi quattordici anni, da proteggere e coccolare. Assieme a lei passò i controlli, entrò nei Distinti Nord e si ritrovò nello Stadio semideserto. Il sole delle cinque di pomeriggio di uno strano sabato di aprile riusciva appena a scaldarlo, ma non era di quel calore che Giulio sentiva il bisogno. Il calore che Giulio cercava in sé, e attorno a sé, è quello che ti sale da dentro fino ad avvamparti. Che ti fa saltare di gioia pronto a devastare in un abbraccio il tuo vicino. Nel frattempo la Curva Sud iniziava a riempirsi e a scaldare la voce, sfidando la maledetta acustica dell’Olimpico che ti fa entrare nel coro quando ormai è finito. Allo stesso tempo partirono i cori dei genoani, pronti ad ingaggiare il loro impari duello e Giulio pensò che gli mancavano i tamburi della sua adolescenza, quelli che iniziavano a suonare dal mattino e non smettevano mai. All’inno si alzò in piedi e si strinse ad Emanuela cantando assieme al lei e il suo amore di padre si confuse con l’orgoglio di chi vede nella propria figlia la sua stessa anima. Giulio immaginò il giorno in cui sarebbe stata lei ad avere una figlia o un figlio accanto allo Stadio e con tutto il cuore sperò di esserci anche lui quel giorno. La partita iniziò e lo Stadio prese a vibrare come un diapason. La squadra percepì questa tensione, questa voglia di vincere, e in pochi minuti trovò il vantaggio e poi il raddoppio con una di quelle magie che puoi vedere anche da lontano, che quando parte il tiro lo sai già prima che sarà gol. Il primo tempo si chiuse senza altri sussulti anche se Giulio percepì una sorta di scricchiolio che preferì scacciare dalla sua mente. I fantasmi di Giulio divennero incubi dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo. Nel volgere di un solo giro d’orologio il Genoa, tutt’altro che rassegnato, trovò la via del gol e poi addirittura quella del pareggio e la squadra sembrò accusare il colpo stanca e smarrita. Fu allora che Giulio iniziò a sentire di nuovo i tamburi dell’Olimpico. In un primo momento pensò che fossero frutto della sua immaginazione, ma poi li percepì sempre più distintamente e capì. Capì che quelli che sentiva erano i battiti impazziti di quarantamila cuori in ansia. Si guardò intorno timoroso che qualcuno lo prendesse per pazzo o per visionario e poi si alzò, lasciò il suo posto e rimase in piedi vicino alla balconata per mettersi là dove potesse dare sfogo alla sua rabbia e alla sua tensione. E di nuovo i tamburi, sempre più forti, sempre più impetuosi sino a sovrastare persino la ola genoana. Giulio vide l’azione del rigore quasi al rallentatore, come se fosse immerso in un acquario. Taddei che tenta una finta e un genoano che lo atterra, il braccio dell’arbitro ad indicare il dischetto. Non resse all’emozione e si diresse verso le scale. Lui i rigori non li vedeva da anni. Lui era uno di quelli dell’84. Giulio fece appena in tempo a vedere Daniele De Rossi che si avvicinava al dischetto, si voltò e si coprì la testa con il cappuccio del giaccone per ritrovarsi ad esultare con altri quarantamila quando il boato dello Stadio intero lo travolse e il tabellone gli confermò che la Roma era tornata in vantaggio. Si fece forza, tornò al proprio posto e sentì nella sua, gelida, la mano della figlia. Non seppe se sentirsi in colpa per questo o se, piuttosto, non sentirsi confortato dalle emozioni che la sua piccola stava provando assieme a lui in quel momento. I quarantamila tamburi dell’Olimpico, nel frattempo avevano ripreso a rullare più forte che mai, mischiati ai cori della sua adolescenza, cantati, finalmente, dallo Stadio intero e così Giulio visse, interminabili, i minuti finali in un crescendo di tensione da lasciarci la pelle. Al fischio finale non ebbe occhi e attenzioni che per Emanuela che, al suo fianco, si era afflosciata esausta al suo posto. Lei, che per tutta la partita non gli aveva rivolto praticamente la parola, gli chiese se davvero la Roma fosse sempre così. “No, non è sempre così, per fortuna” le rispose Giulio “ma è così che si diventa romanisti, con i tamburi dell’Olimpico”. “Ma guarda pà che all’Olimpico mica ci sono i tamburi!” gli rispose assennatamente Emanuela. Sì che ci sono i tamburi all’Olimpico, Emanuela, pensò Giulio, un giorno anche tu imparerai ad ascoltarli… e, in silenzio, prese la figlia sotto braccio e uscirono dallo Stadio. Ognuno ha il suo tamburo (*) Dedicata all’Afgano, alla sua piccola e a tutti quelli che a Roma-Genoa hanno lasciato qualche anno di vita. |